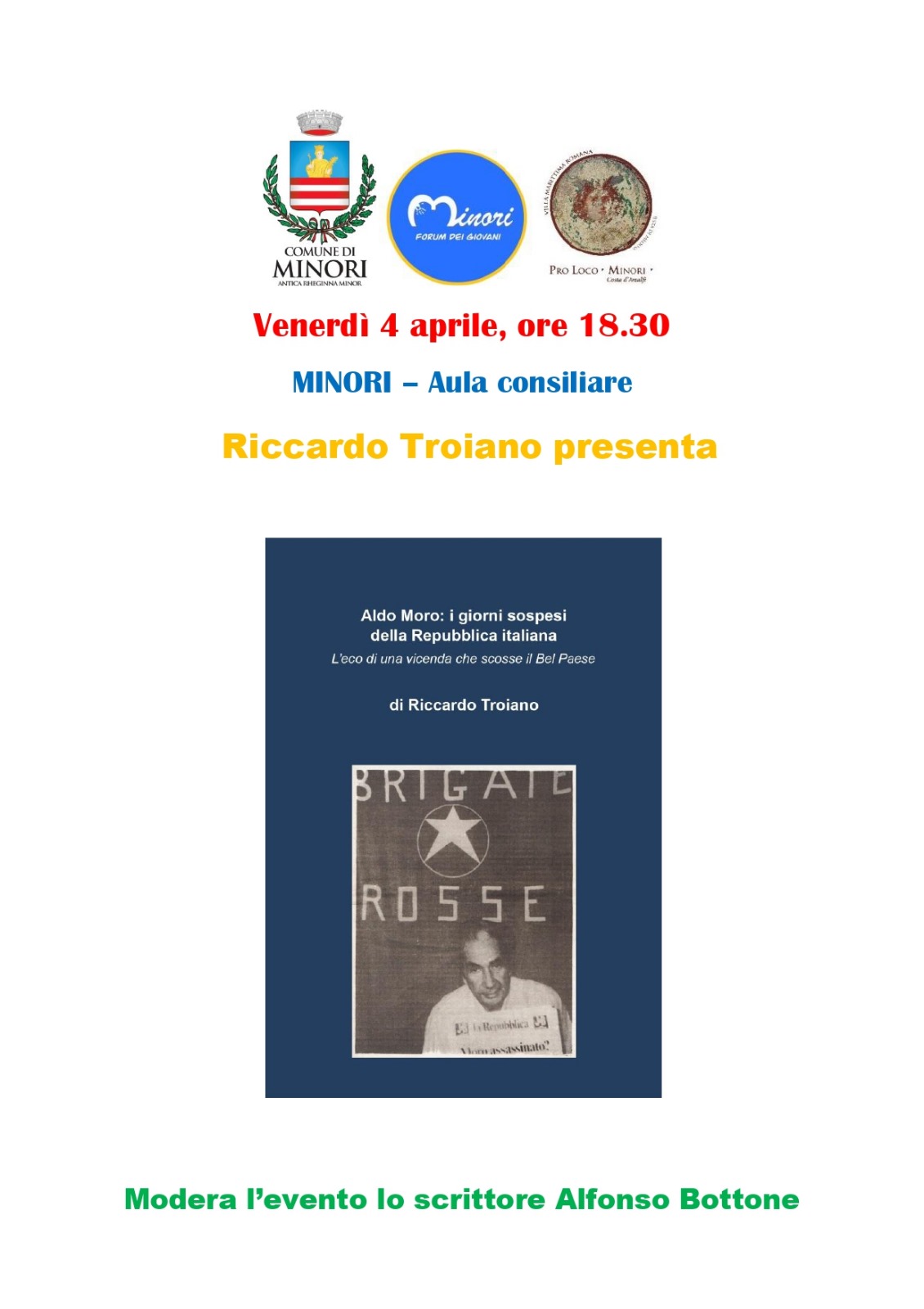Catullo e Virgilio erano convinti che gli etruschi fossero tutti obesi, e non lo affermavano nei loro gai colloqui tra un banchetto e un altro e tra un’opera letteraria e l’altra, ma lo hanno riportato convintamente l’uno nella sua raccolta di poesia Liber, nella prima parte detta nugae, l’altro nelle sue Georgiche. Ma a raggiungere tali stili alimentari erano soprattutto i ricchi che potevano ampiamente attingere agli estesi allevamenti dell’antico popolo, senza contare vini e olii, produzioni per le quali gli etruschi erano rinomati e che esportavano fino in nord Africa, passando per la Spagna e la Francia. La cucina etrusca era piuttosto semplice, anche se di estremo gusto, non proprio molto ricercata, infatti non mancavano mai sulle tavole (alcune) il fegato cucinato con vino e miele, salsicce accompagnate da legumi, soprattutto piselli, abbondanti fritture di pesce, le stesse uova condite con miele selvatico, le onnipresenti focaccine etrusche, semplici o con ripieno di olive o fichi. Ovviamente, molto dipendeva dal modo in cui le pietanze erano preparate, il ruolo di chi aveva in mano le “sorti” della cucina era fondamentale. Nell’antica Roma l’arte culinaria rappresentava un aspetto fondamentale della vita e dell’economia dei cittadini, generalmente i ruoli erano divisi tra chi si interessava dei cibi consumati in fretta, in una sorta di fast food (vedi Pompei), affidati ai cosiddetti “opsonatores”, veri e propri gestori di tavole calde; gli addetti alle cotture nei forni e nei fornelli erano chiamati “fornacarii”; nella cucine regnava incontrastato l’”archimagirus”, un vero e proprio chef, coadiuvato da diversi “coqui” e dai “crustularii” e “dulciarii”, questi ultimi addetti alla preparazione dei dolci. Ma i “crustularii” proponevano i loro prelibati biscotti, appunto “crustulum”, anche nelle vie delle città, come avviene oggi in molti mercati, gridando e decantandoli, attirando curiosi e potenziali degustatori. Questi biscotti erano particolarmente ricercati, anche perché si consumavano dopo i vari riti religiosi, mangiati da sacerdoti, inservienti dei templi e partecipanti alle cerimonie, cui spettava spesso il compito di donarli, forse erano offerti anche come premio per i discepoli più meritevoli dal grande poeta Orazio. Il modo di mangiare nell’antichità, la varietà di cibi, la frequenza dei pasti erano anche indice di posizione sociale, rappresentavano una vera e propria carta d’identità virtuale, lo storico greco antico Diogene Laerzio distingueva i ceti in base alla frequenza dei pasti: “se uno è ricco [mangia] quando vuole, se uno è povero, quando può”. Ma l’autentico e strepitoso fuoriclasse della gastronomia dell’antica Roma fu inequivocabilmente Marco Gavio Apicio, lo chef degli chef. Nato intorno al 25 a.C., fu personaggio, e cuoco, stravagante, ambito dai circoli più esclusivi dell’alta società e idolatrato dalla plebaglia, temuto dai rigoristi proprio, forse, per le sue ricette geniali e insolenti. Le realizzava personalmente, cucinando “talloni di cammello, intingoli di creste tagliate a volatili vivi, triglie fatte morire nel garum della migliore qualità, oche ingrassate nei fichi secchi e ingozzate con mulsum (una mistura di vino e miele) per fare ingrossare loro il fegato, lingue di usignoli, di pavoni e di fenicotteri, utero di scrofa sterile”. E’ certamente suo il testo più famoso di gastronomia dell’antichità, il De Re Conquinaria, una raccolta di ricette pubblicata postuma (e neanche da un curatore molto attento) intorno al IV sec. d.C., un manuale di gastronomia che è anche uno spaccato unico dei gusti e della cultura di quel tempo. Apicio elaborò e descrisse ricette in maniera precisa, alcune funsero da riferimento per quella che sarebbe diventata la cucina rinomata dei tempi a seguire e di oggi, con preparati che richiameranno le omelette, il purè di verdure, gli spezzatini, la polpetta e la fricassea, riportando descrizioni e disegni degli attrezzi da cucina e studi medici dell’antica Grecia. Riflettendo, forse il cibo è anche un modo per capire un po’ chi siamo e vivere meglio, anche con chi amiamo. Il manuale di salute più famoso del Medioevo, il Regimen Sanitatis Salernitanum, della Scuola Medica Salernitana, fra lo sconfinato sapere ci parla anche di alimenti, di alimenti naturali, di stati d’animo e delle peculiarità delle stagioni, propone delle regole di vita, semplici ma imprescindibili. Scritto da Arnaldo da Villanova intorno al XIII secolo, è incentrato intorno al principio di equilibrio, con l’ambiente e con se stessi, ci riporta essenziali dettami per lo star bene, veri e propri “assaggi” di cultura dell’alimentazione: mangiare e ingrassare con equilibrio; astenersi dalla rabbia (“mente gioiosa, riposo e dieta moderata”); sì ai formaggi, ma solo quelli freschi; mangiare solo quando lo stomaco è vuoto; fare una passeggiata dopo aver mangiato. Il cibo è stato e resta anche civiltà, patrimonio intellettuale: nell’antica Roma “il prandium e la cena erano i due tipi basilari di pasti conosciuti dai Romani, e definivano due categorie culturali completamente diverse e anzi opposte. Da un lato, il prandium era il pasto dei Romani impegnati nella guerra, nella politica e nelle attività ordinarie. Nel prandium il pasto del contadino e quello del soldato in pratica coincidevano, con la differenza che il primo si nutriva essenzialmente dei prodotti del proprio orto, mentre il soldato mangiava pane, e solo secondariamente legumi o carne. Con la cena era tutta un’altra storia. I Romani vi prendevano parte in quanto uomini liberi, e pur se magari sobria e poco lussuosa, la cena costituiva un’esperienza a se stante, distaccata dalla dimensione della quotidianità. La cena per il Romano appartiene, per l’appunto, al tempo dell’otium, ossia del divertimento e della pace. L’otiosus non è un soldato, ma non è neppure occupato in un’attività civica; è chi si gode il meritato riposo. […] Anche in altro modo gli antichi Romani davano mostra di notevole spirito pratico: in origine, la focaccia assolveva le funzioni di piatto Su di essa si disponevano uova, prosciutto, formaggio, olive, funghi e quant’altro, e poi il tutto scompariva nelle fauci del commensale, senza che si dovesse provvedere a raccogliere i piatti e a lavarli. Una soluzione, questa, che doveva fare la gioia delle casalinghe (e degli schiavi) del tempo, e in cui non è difficile individuare l’origine della nostra pizza.” (cfr. La Cultura Alimentare e l’Arte Gastronomica dei Romani. Contributo alla Filosofia dell’Alimentazione e alla Storia Culturale del Mondo Mediterraneo, A. Jori, Accademia Nazionale Virginiana di Scienze, Lettere e Arti). Il nutrimento rappresenta senz’altro un’identità, ma azzera la sensazione di alterità, anzi avvicina, fa appunto “vivere con”, riguarda la dimensione soggettiva così come quella di gruppo, quella del mangiare è un’esperienza, più che un mero cibarsi, attiva dei principi conoscitivi ed emozionali che richiamano strettamente l’identità e la cultura, è uno “spazio speciale d’integrazione”. Siamo anche un po’ ciò che mangiamo, ma anche con chi e come mangiamo. Ricordiamolo.